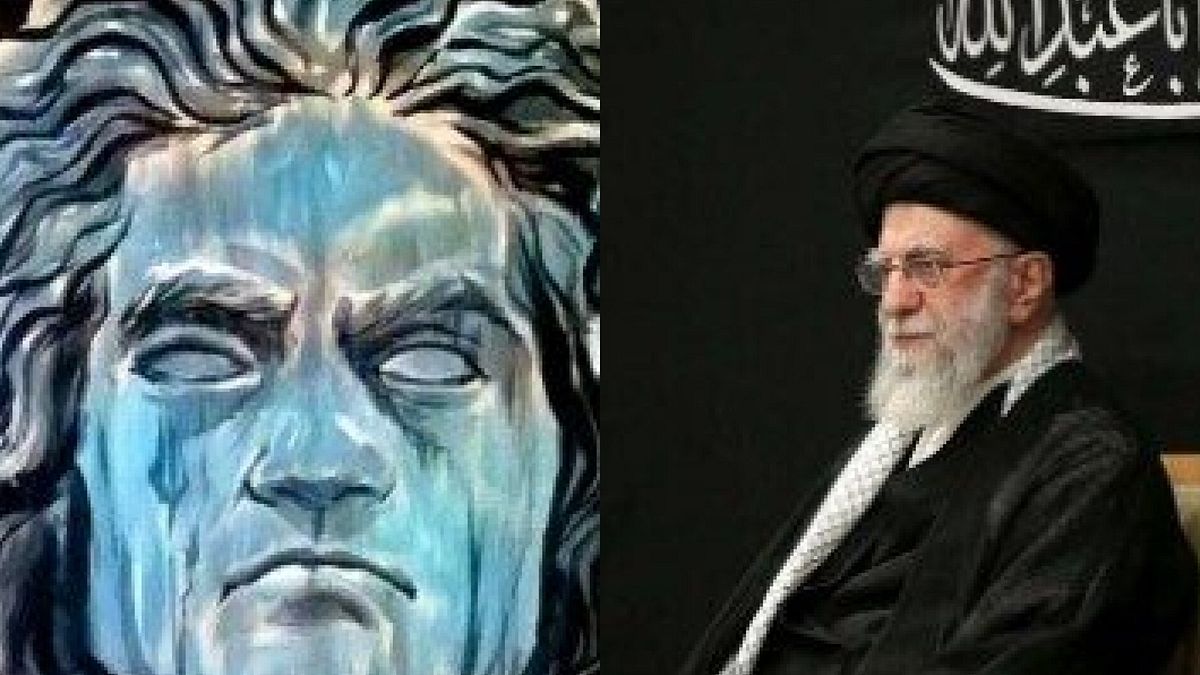Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, gli abitanti della Repubblica Islamica si trovarono a fronteggiare un cambiamento radicale. La musica, da sempre considerata un elemento fondamentale del patrimonio culturale nazionale, subì un divieto che lasciò molti increduli. La transizione da una cultura influenzata dall’Occidente, definita qarbzadegi, a un clima di sospetto nei confronti di qualsiasi espressione musicale, specialmente al di fuori di Teheran, fu traumatica per gli artisti e per il pubblico.
La musica come strumento di propaganda
Nel settembre del 1980, con l’inizio del conflitto tra Iran e Iraq, i leader della rivoluzione khomeinista si resero conto del potenziale della musica come mezzo per sollevare il morale della popolazione e per sostenere la propaganda governativa. Di conseguenza, la musica tradizionale e quella religiosa furono riammessi, lasciando in un limbo i musicisti che si chiedevano se le loro esibizioni fossero lecite o illecite. La musica classica, in particolare, sollevò interrogativi, poiché i dirigenti della neonata Repubblica Islamica non avevano una linea chiara su come gestirla. Pur non contenendo testi censurabili, questa forma d’arte affondava le sue radici in una cultura che veniva vista con disprezzo. Così, tra oscillazioni di autorizzazioni e divieti, la musica classica si affermò come un sofisticato strumento di protesta, sempre a rischio di censura.
Storia di aperture e chiusure
Le sanzioni imposte da alcuni Paesi europei sull’Iran limitarono per lungo tempo la possibilità degli artisti di accedere a strumenti musicali moderni. Grandi musicisti tornavano in patria portando con sé nuove sonorità, che spesso venivano suonate clandestinamente, fondendosi con le tradizioni locali. Negli anni Ottanta, il musicista Mohammad-Reza Lofti, dopo essere fuggito dall’Iran, si stabilì a Firenze e tentava di apprendere la lingua italiana attraverso termini musicali come “andante” e “allegretto”.
In quel periodo, a Teheran si cercava di rivitalizzare forme d’arte come il Tazieh, una tradizione iraniana simile all’opera, ma legata a eventi religiosi. La musica di compositori come Bach, che visse una vita tranquilla, veniva percepita come proibita e rivoluzionaria. Oggi, in una serata primaverile alla Vahdat Hall di Teheran, il pubblico è consapevole che le esibizioni di Beethoven possono essere interrotte da un’email del ministero. I tempi in cui lo Scià Nasser Al-Din portò l’opera occidentale in Iran sembrano lontani, quando commissionò un inno a Jean Baptiste Lemaire, intitolato “Giovane Iran“, cantato dal noto artista Nazeri.
La passione dello Scià per la musica classica
Lo Scià Nasser Al-Din fu anche il promotore della costruzione del Teatro dell’Opera vicino al Palazzo di Golestan, un edificio che doveva competere con quelli di Vienna e Parigi. Oggi, di quel progetto non rimane nulla, così come molte altre istituzioni create durante il regno dello Scià Pahlavi. Quest’ultimo, in un periodo di forte occidentalizzazione, fondò l’Orchestra Sinfonica di Teheran nel 1933, la Tehran Opera Company nel 1957 e la National Ballet Company nel 1958. La nuova sala dell’opera, chiamata Roudaki Hall, è oggi conosciuta come Vahdat Hall.
Le fragili aperture musicali
Tuttora, l’attività musicale si concentra attorno a questo teatro, sotto la supervisione del governo. Nel marzo del 2014, si verificò un evento storico: per la prima volta dopo la rivoluzione, una cantante si esibì in pubblico, presentando un nuovo allestimento di Gianni Schicchi di Puccini con il Teheran Opera Ensemble. Questo avvenne nei primi anni dopo l’elezione di Hassan Rouhani, che nel 2013 sembrava promettere un’apertura, ma che si rivelò fragile. Qualche mese prima, era già iniziato il rilancio dell’Orchestra Sinfonica di Teheran, diretta da Ali Rahbari. Tuttavia, la censura tornò a farsi sentire rapidamente, con Rahbari che si oppose fermamente al trattamento riservato agli artisti. La situazione a Teheran cambiava rapidamente e il regime mostrava segni di preoccupazione per il controllo, rimandando concerti anche a pochi minuti dall’inizio.
Un pubblico giovane e appassionato di musica classica
A differenza di molte altre nazioni, in Iran la musica classica non è mai stata relegata a un semplice oggetto di studio scolastico. Essa è stata assimilata come qualsiasi altra forma musicale, trasformandosi in uno strumento di protesta. La musica classica, priva di testi espliciti, riesce a comunicare messaggi attraverso le note, aprendo spazi culturali in un sistema autoritario.
Il volume della musica si alza
Un esempio di questa resilienza è il Fajr International Music Festival, al quale nel 2017 partecipò la Fondazione del Festival Pucciniano insieme all’Orchestra Sinfonica di Teheran. Nello stesso anno, il direttore Riccardo Muti guidò un concerto con musicisti iraniani e italiani al National Garden di Teheran, nell’ambito del progetto “Road of Friendship”. Tuttavia, la situazione rimane complessa, con artisti che a volte vengono esclusi senza spiegazioni. Mentre la musica continua a diffondersi per le strade di Teheran, Tabriz e Isfahan, cresce la speranza che il suono della musica classica possa finalmente rompere le barriere di un regime che teme il potere della cultura.