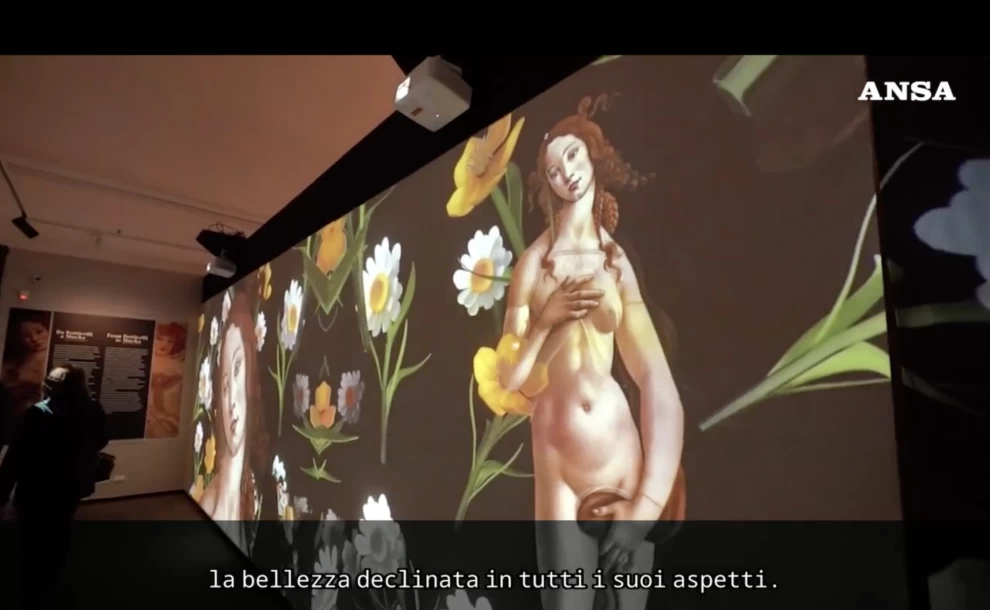A Padova, il 15 aprile 2025, si radunano visitatori da ogni parte per scoprire il significato profondo delle opere di Andrea Mantegna, il celebre pittore nato a Isola di Carturo nel 1431 e scomparso a Mantova nel 1506. Il suo genio artistico continua a influenzare e affascinare, in particolare per la sua interpretazione di scene bibliche, come quella dell’orto degli ulivi.
Il periodo padovano di Mantegna
Nel 1455, mentre Mantegna era impegnato nella realizzazione della Cappella Olivetari, dipinse la prima delle sue due celebri opere intitolate Orazioni nell’orto, oggi conservata presso la National Gallery di Londra. In questo dipinto, l’artista rappresenta l’episodio biblico in cui Gesù vive la sua angoscia nell’orto degli ulivi, un momento di intensa solitudine prima della cattura. Mantegna sceglie di collocare questa scena in un paesaggio montano, richiamando l’attenzione sul “Monte degli Ulivi” menzionato nel Vangelo di Luca.
Mentre i Vangeli di Marco e Matteo menzionano un “villaggio” chiamato Getsemani, Mantegna arricchisce la sua interpretazione con la presenza di una città, creando un dialogo tra natura e urbanizzazione. Questa scelta rappresenta una delle caratteristiche distintive del suo lavoro, dove il paesaggio non è solo un contesto, ma un attore fondamentale nel racconto visivo.
Il paesaggio e la città ideale
Le montagne, che potrebbero essere ispirate dalle Dolomiti, si ergono maestose sopra una città ideale fortificata, dove elementi medievali si fondono con strutture romane. Mantegna non rappresenta solo la natura, ma la intreccia con i resti di una civiltà antica, quella romana, che ha lasciato un segno indelebile nel territorio veneto, specialmente a Verona, dove l’artista trascorse parte della sua vita.
La città che Mantegna crea è al contempo astratta e realistica, incastonata in un paesaggio di rocce e vegetazione. I personaggi, simili a sculture estratte dalla pietra, si muovono in questo spazio che è tanto naturale quanto antropico. La visione di Mantegna trasmette un senso di grandezza e di peso, con le montagne che sembrano sovrastare non solo la civiltà, ma anche i protagonisti della narrazione.
La simbologia e il dramma di Gesù
Nel dipinto, Gesù riceve la visita di un angelo, un elemento che Mantegna attinge dal Vangelo di Luca: «Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo». Tuttavia, gli angeli portano con sé simboli della Passione, come la colonna del martirio e la croce, accentuando il dramma che si svolge. La preghiera di Gesù, “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice”, risuona in un contesto che non è neutro, ma carico di tensione emotiva.
L’arte di Mantegna non si limita a rappresentare la scena, ma costruisce un’atmosfera di profonda angoscia, evidenziando il contrasto tra la serenità della natura e il tumulto interiore di Gesù. Le montagne, con le loro cime, simboleggiano l’arrivo delle forze oscure, mentre i personaggi come Giuda e gli apostoli addormentati si inseriscono in questo dramma, rendendo il paesaggio un protagonista essenziale.
Il confronto con Giovanni Bellini
Un interessante confronto può essere fatto con un’opera coeva di Giovanni Bellini, anch’essa intitolata Orazione nell’orto, conservata alla National Gallery di Londra. Nella versione di Bellini, la roccia assume una forma più morbida e accogliente, quasi come un inginocchiatoio, creando un’atmosfera più dolce e armoniosa.
Mentre in Bellini la natura avvolge e integra i personaggi in un’armonia complessiva, Mantegna crea un equilibrio più complesso e difficile tra la storia e la natura, dove il paesaggio diventa un elemento di tensione e conflitto. Questa dualità tra le due opere riflette le diverse visioni artistiche del Rinascimento, con Bellini che celebra l’armonia e Mantegna che esplora la drammaticità dell’esistenza umana.